Intervista a Giulia Caminito
Ho scoperto questo romanzo molto casualmente. Ero a Bologna e avevo iniziato da poco un corso di editoria in cui ci era stato consigliato di andare nelle librerie, osservare i libri in primo piano e le ultime uscite. Un semplice esercizio di indagine del mercato.
Era un periodo molto confuso della mia vita, avevo terminato i miei studi da pochi mesi e avevo chiuso con il solito lavoretto che non mi portava alcun profitto né economico, né mentale. Avevo deciso di fare un salto nel vuoto, cercare nuovamente lavoro, preferibilmente in un campo più vicino ai miei desideri, alle mie capacità e ai miei interessi. Insomma, un’impresa quasi impossibile considerando la precarietà dei nostri tempi. Sono entrata in libreria con tutti questi pensieri, con questo peso sullo stomaco e con la mente completamente annebbiata dalle mie paure, ma anche con un po’ di fame; la fame di scoprire cosa ci fosse in riserbo per me nel futuro, la fiamma che si ha dentro quando hai ventisei anni e il privilegio di poter sognare ancora per un po’.
Io sono una di quelle persone che sceglie i libri dalla copertina, attirata dal titolo, e che crede che la scelta non sia mai casuale: consapevoli, o no, leggiamo le storie di cui abbiamo bisogno. Quel giorno sono stata attratta da Il male che non c’è di Giulia Caminito. Il titolo mi ha fulminata e la scelta è stata immediata.
Il male che non c’è è stato un libro difficile da leggere poiché il riflesso di uno stato d’ansia che conosco molto bene. Quel male l’ho visto e l’ho sentito insieme a Loris, il protagonista del romanzo.
Non riuscendo a togliermi di dosso questa lettura, mesi dopo ho voluto parlarne con l’autrice Giulia Caminito. Il risultato è stato uno scambio ricco e profondo, uno svisceramento di questo male così invisibile, quanto concreto.
Il male che non c’è: quanto credi sia importante quel “non” nel titolo? E quanto è stato rilevante il concetto di negazione nella costruzione del personaggio di Loris?
Il titolo è nato mentre facevo delle ricerche sull’ipocondria, e tra le varie definizioni c’era quella di male che non esiste, male che non c’è. Sono partita proprio da questa negazione che mi sembrava importante nella costruzione del personaggio, infatti, Loris è un non visto; una persona che percepisce dolori anche fisici che sembrano dei sintomi, ma non vengono mai riconosciuti come tali. Quando lui si fa visitare, o quando lui li evoca, li racconta ai medici, ai familiari, ma anche alla compagna, in qualche modo non percepiscono questo come un reale malessere, come una reale patologia. È un discorso sulla realtà. Nei periodi di crisi piscologiche, che per alcuni possono anche corrispondere ad una condizione di vita costante, c’è una realtà per la persona che le vive e c’è una non realtà per quelle che si trovano fuori, questo proprio perché i malesseri mentali non sono mai stati percepiti come una realtà da accertare e anche da poter curare facilmente. L’ipocondria, come anche gli attacchi di ansia o di panico generalizzati, sono considerati un po’ come delle cose di cui l’individuo si deve occupare da sé e che non sono adatte alla società in cui viviamo che è molto performativa, ma anche affermativa in cui bisogna sempre affermarsi e affermare quello che si vuole ed essere in grado di ottenerlo; questa negazione è proprio la condizione negativa di sottrazione in cui si trova Lois rispetto la propria identità, ma anche rispetto al non riconoscimento degli altri che credo corrisponda a un non riconoscimento sociale.
Catastrofe, nonché la personificazione del panico, dell’ansia, è coprotagonista di Loris, una sua estensione un po’ mutaforme. Particolare è il contrasto tra il nome che allude a qualcosa di tremendo e al suo ruolo nella vita di Loris, quasi come se lo rassicurasse ad ogni sua apparizione, a volte in modi anche bizzarri: perché hai scelto una rappresentazione pittoresca dell’ansia?
Io ho scelto Catastrofe, anche il nome, per varie ragioni. La prima è che, appunto, è qualcosa che incombe nella vita di Loris, la sconquassa, ne distrugge alcuni elementi; dall’altro lato è proprio l’etimologia della parola che porta anche alla distruzione, ma anche alla parte construens, quindi alla parte di rinascita, infatti, catarsi e catastrofe sono due parole che hanno la stessa etimologia. Volevo rappresentare l’ansia e l’ipocondria in maniera sfaccettata: da una parte Catastrofe è un personaggio che perseguita Loris, è un peso per lui molto forte che interviene per disturbare la sua quotidianità, le sue attività lavorative e anche il suo rapporto con la compagna però, a sua volta, è una possibilità per Loris di difendersi dal mondo. Credo profondamente che, a volte, l’ansia sia un nostro modo di reagire al mondo, per difenderci e per usarlo come una scusa verso noi stessi e verso gli altri per non agire, e questo accade anche per Loris, che si sente confortato da Catastrofe che, alla fine, è quasi come se si sostituisse a Joe, la sua ragazza; ne prende mano a mano il posto, diventa sempre più umana, sempre più vicina a una figura femminile adulta e anche all’immagine quasi erotica della vita con la compagna che lui non ha più. Volevo che fosse multisfaccettata proprio perché credo che il rapporto che noi abbiamo con un disturbo mentale che, quindi, è dentro la nostra mente, da una parte la colonizza dall’altra cambia spesso disegno perché prende e succhia nutrimento dalla mente stessa, dal suo immaginario e dalla personalità di Loris in questo caso.
In questo romanzo ci sono due giovani adulti che sembrano avere due vite completamente diverse: Loris ha trent’anni, è ancora stagista in una casa editrice e vive in un monolocale grazie al supporto finanziario dei suoi genitori; dall’altro lato c’è Jo, la sua ragazza, o la persona che aveva amato e da cui era stato amato molto tempo prima che la sua ipocondria iniziasse a farsi sempre più spazio nelle loro vite. Jo lavora per una grande azienda e vive la sua giovinezza con semplicità e leggerezza, ma non ama più Loris, da tempo ormai; lui “non è più portabile”. Cosa rappresenta per te questo rapporto? Durante la lettura impariamo a conoscere Loris, ma chi è Jo?
Mi interessava parlare di un tema come quello del lavoro, ma anche della vita emotiva e della crescita personale da punti di vista diversi in modo che ci fosse un contraltare rispetto alla posizione di Loris. È chiaro che anche Joe ha le sue difficoltà perché convivere con un amore finito che si cerca ancora di rianimare non è una cosa particolarmente edificante. Io ho portato questo rapporto nel romanzo perché ho vissuto una relazione simile, molto lunga, e per versi anche molto diversa. Mi sembrava importante, però, provare a parlare di quelle relazioni che nascono in età molto giovane e che durano per molto tempo, anche quando le persone ormai sono estremamente diverse e distanti, ma c’è ancora quella familiarità che cerca di tenere appeso il legame e di non tagliare il filo che unisce le due persone. La figura di Joe, quindi, che è opposta a quella di Loris, lo fa sentire ancora più inetto, ancora più incapace, più inquieto e lo rende anche testardo, a volte crudele perché all’interno delle relazioni molto strette sappiamo che, a volte, emergono delle parti di noi che sono anche terribili. Quindi, questo era il tipo di racconto che volevo provare a fare e Joe, come anche Catastrofe e Tempesta, ha un soprannome perché è come se fosse, anche lei, un personaggio della mente di Loris. Questo è un libro Loris-centrico, perciò Joe viene descritta soltanto nel modo in cui Loris l’ha vissuta e la vede; tuttavia, fuori da questa descrizione, rimane il non detto della realtà anche di questa giovane ragazza che cerca di lavorare, fare sport, vivere la sua vita ed è un po’ trascinata verso il basso da questa relazione che ha dei contorni un po’ tossici.
Un’altra questione che vorrei indagare è la scelta di rappresentare il maschile in termini decisamente opposti alle dinamiche patriarcali. A posteriori, per fare un riferimento musicale, Loris mi fa pensare alla canzone di Lucio Corsi “Volevo essere un duro” in cui viene distrutta l’immagine del maschio duro e forte, coraggioso, potente e valoroso. Loris è l’opposto dell’eroe, è un antieroe ed è debole mentalmente e fisicamente: cos’è cambiato nella narrazione del maschile nella letteratura oggi?
Penso che siamo in un periodo in cui c’è stata già una grande decostruzione dell’essere uomo, del maschile e siamo un po’ in una terra di mezzo in cui per molti è difficile orientarsi negli anni della formazione della propria identità. Ci sono ancora tantissime cose della mascolinità che abitano gli uomini nel rapporto con se stessi e con le donne, e anche nei rapporti tra uomini; ci sono anche tante vulnerabilità che vengono esposte e io volevo proprio partire da questo maschile fragile, maschile in sottrazione che comunque ha una sua umanità e ha anche una sua spigolosità, una sua scorrettezza. Per me Loris è un antieroe, non è facile empatizzare con lui; è anche un’anima sofferente, un giovane uomo che non riesce a capire chi è, non riesce a trovare se stesso, deve affrontare dei traumi della propria infanzia ed è una cosa che fa con grande fatica. A me interessava scrivere un personaggio maschile perché non avevo mai fatto un romanzo con un unico personaggio maschile al centro ed è una cosa con cui mi volevo confrontare perché gli uomini fanno parte della mia vita e la scrittura è un campo anche di indagine per me. È un campo di sfida, di possibilità, che mi permette di andare in direzioni nella vita impossibili cioè quelle di raccontare un uomo dall’interno e nella sua intimità. Credo che anche molti scrittori, soprattutto della mia generazione, stiano raccontando un maschile più vulnerabile. Mi piacerebbe che loro si confrontassero con il femminile provando a tracciarne anche i contorni della vulnerabilità senza pregiudizi o senza luoghi comuni. Ecco, io con questo personaggio ci ho provato.
Loris è un personaggio che disturba; non è un personaggio che suscita pietà nel lettore, al contrario potrebbe infastidirlo e innervosirlo. Loris è irriverente, testardo, scorbutico, ma io ho empatizzato con lui, l’ho capito e l’ho anche difeso. Perché hai deciso di raccontare un personaggio ipocondriaco senza fare affidamento alla pietas dei lettori e delle lettrici, ma a delle emozioni opposte come rabbia e fastidio? Cos’è per te l’elemento di disturbo presente nella personalità di Loris?
Sono un po’ stanca dei personaggi che cercano a tutti i costi il plauso dei lettori e delle lettrici; sono molto più attratta dai personaggi disturbanti, dai personaggi con cui non è facile empatizzare e dai personaggi anche fastidiosi e che disturbano nella lettura, perché credo che possano provocare degli spostamenti in chi legge di una certa profondità o comunque far sorgere delle domande anche solo per contrasto. Quindi, il personaggio di Loris è anche un burbero, è un po’ pieno di sé, ma è contemporaneamente solo; è denudato, con la pelle sottile. Non volevo raccontare l’ipocondriaco come vittima e basta, volevo raccontare una personalità, un giovane uomo che diventa ipocondriaco, ma che comunque mantiene la propria personalità. Ognuno di noi reagisce ad un disturbo mentale in maniera molto diversa; volevo raccontare il suo senso di colpa, ma anche il suo senso di impotenza, e spesso la frustrazione e l’impotenza ci rendono anche rabbiosi, infastiditi e questa rabbia non fa altro che alimentare il suo disagio, non lo porta da nessuna parte perché è una rabbia che implode e che non fa altro che alimentare la sua ipocondria, la sua ansia, la sua incapacità. So che questo è un personaggio che può portare a una certa distanza nella lettura e che l’empatia nei suoi confronti, forse, è un’empatia che arriva soltanto in alcuni momenti o che non arriva mai, però per me resta un personaggio a tutto tondo, un personaggio umano e nell’umanità ci sono anche i chiaroscuri e non c’è l’essere eroi o l’essere guerrieri o l’essere vittime e basta. C’è sempre qualcos’altro.
I momenti di dolore e di ansia di Loris sono intervallati dai ricordi di un’infanzia spensierata e felice con il nonno Tempesta. Tutto il romanzo ruota attorno a questa figura alternativa di adulto, diverso dai genitori opprimenti e iperprotettivi, ma libero a contatto con la natura e la campagna. Un ritorno allo stato di fanciullezza come cura dal presente corrotto dalle aspettative sociali, ma anche il passato come cura del presente: credi davvero che possa funzionare per ritrovarsi e per sopravvivere al grigiore dei meccanismi del capitale?
La figura di Tempesta è una figura centrale e catartica, invece che catastrofica. Riconnettersi con i ricordi dell’infanzia, cercare di tornare in quei luoghi e attraversare il dolore che Loris ha completamente accantonato e che non ha voluto affrontare, vuol dire anche cercare di accettare le cose terribili e dolorose che succedono nella nostra vita e affrontare la perdita. Io volevo che questo mondo con Tempesta fosse un mondo naturale, pratico, che fosse un mondo in cui il fallimento viene accettato quando, per esempio, si pianta qualcosa che non cresce, quando si fanno degli innesti che non funzionano, quando si aspettano le ciliege, ma in quella stagione non ne cresce neanche una, e quindi sì, ci possa essere della tristezza, ma ci debba anche essere un andare avanti, un ingegnarsi, un trovare una soluzione e accogliere quello che è accaduto. Nel finale mi piaceva l’idea di lasciare una scia luminosa in questo percorso che Loris fa nel rientrare nell’orto, in questa figura inedita rispetto al resto della narrazione che appare alla fine. Volevo lasciare un finale un po’ simbolico che è, per me, la metafora di quando uno soffre fortemente di ipocondria, un continuo scavare alla ricerca di qualcosa che potrebbe esplodere, ma il giardino è rovinato da questa ricerca; il giardino, che è il corpo, si indebolisce se viene continuamente frugato, se viene continuamente inquisito. E poi, alla fine, che cosa c’è in questa scatola? Ecco, questa è la domanda. Una volta che l’hai trovata può contenere qualcos’altro; può sorprenderti scoprire che non stavi cercando la cosa giusta. In questo doppio finale volevo provare a raccontare come il passato possa, a volte, o nella maggioranza dei casi, se è analizzato, se è attraversato, se è accolto, aprire una speranza, una possibilità anche per una guarigione, per una cura.
Io, alla fine, ci ho visto della speranza in quell’infanzia ritrovata ed è quello da cui sono ripartita quando non sapevo cosa fare della mia vita. Allora mi sono chiesta: cosa mi piaceva fare da bambina?
Di Carmenrita Lucente

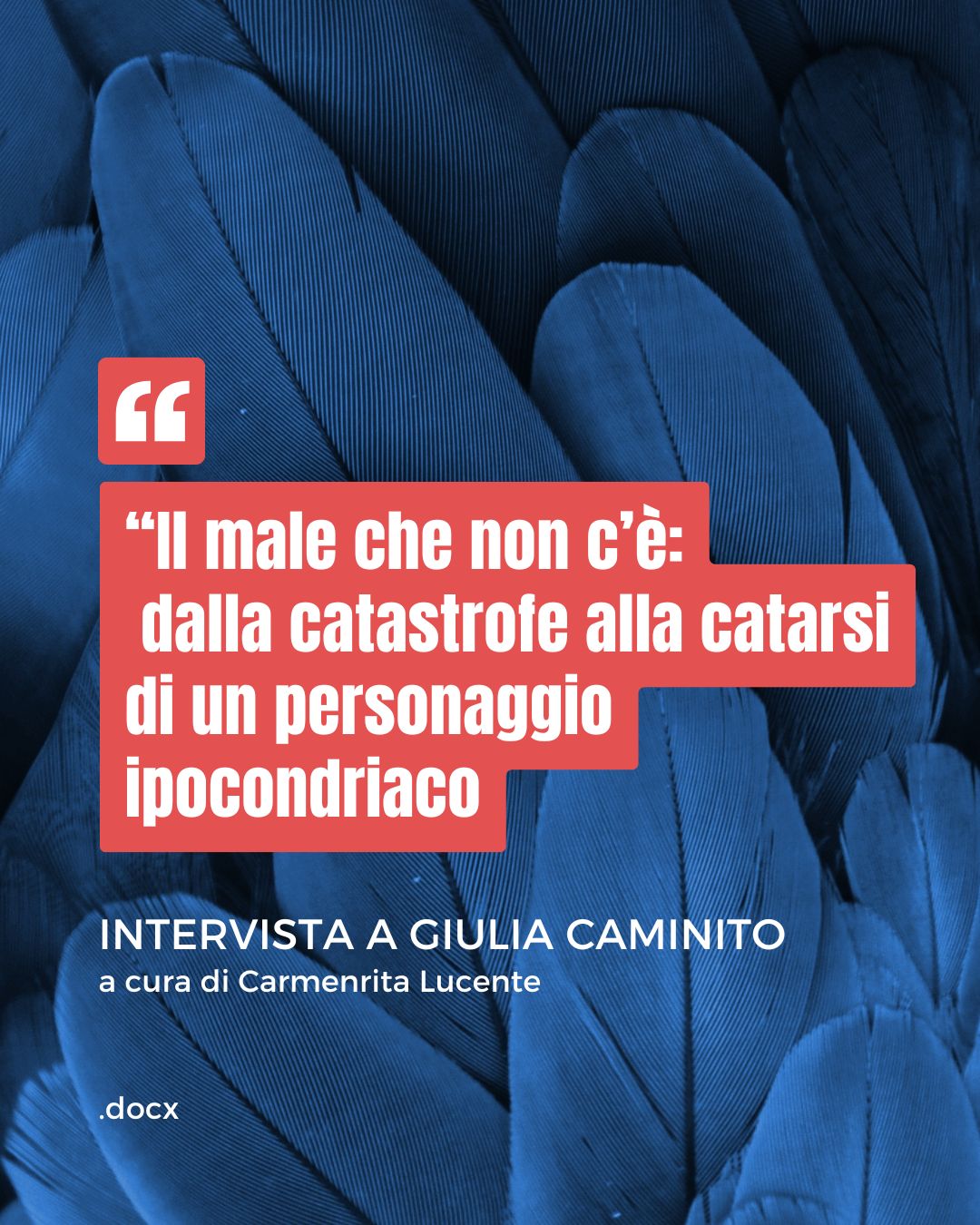
Lascia un commento